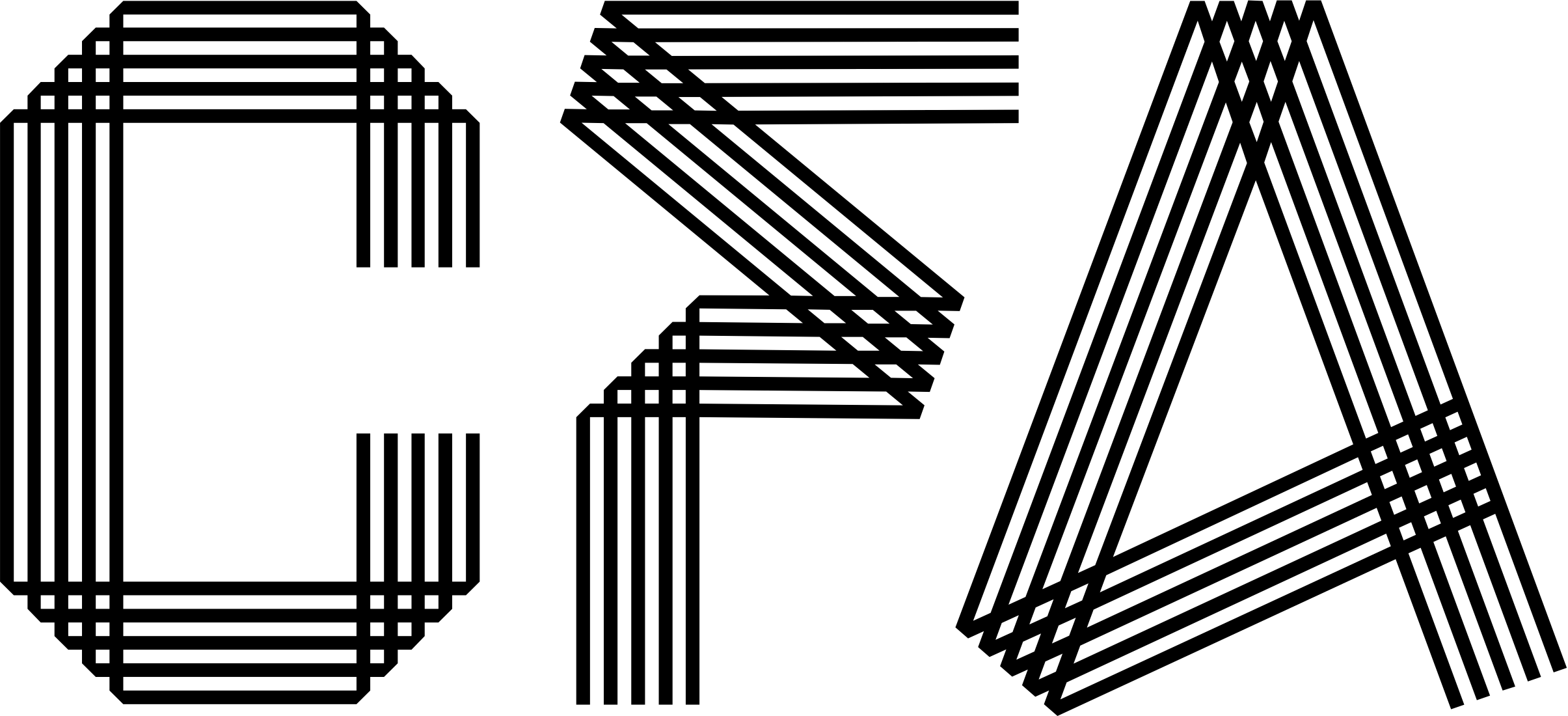James Bradburne e la rivoluzione antropologica di Brera
Abbiamo chiesto al direttore James Bradburne di ripercorre il percorso che lo ha condotto all’originale impostazione didattica introdotta nella Pinacoteca di Brera.
“Ciò che distingue oggi la Pinacoteca di Brera dagli altri musei è il fatto che io sono arrivato con un approccio didattico ben preciso e abbastanza sviluppato su precedenti esperienze”: esordisce così James Bradburne quando lo incontriamo nel suo ufficio all’ultimo piano della Pinacoteca di Brera. “Forse la mia visione deriva dal fatto che non ho avuto un percorso tradizionale”, continua. “Per esempio, sono uno dei pochissimi direttori di museo, in Italia, che non proviene dalla storia dell’arte”. Architetto, designer e museologo, in quattro anni alla guida del museo milanese, Bradburne ha portato il numero di visitatori di Brera a 1.350.000, ovvero a un aumento del 40 per cento rispetto all’affluenza media degli anni precedenti. Ma questi valori non vanno intesi in termini assoluti, poiché il record di Bradburne non è stato raggiunto ricorrendo a mostre blockbuster, bensì investendo esclusivamente sulla valorizzazione della collezione permanente e prestando una particolare attenzione al tema dell’inclusione, ovvero alla possibilità di aumentare il grado di partecipazione dei visitatori. Ora che il direttore che è stato riconfermato nel suo ruolo per altri quattro anni, siamo venuti a chiedergli di raccontarci quale sia la matrice culturale che gli ha permesso di rivoluzionare l’approccio alla fruizione del museo.


Non serve riportare l’elenco delle novità didattiche avviate a Brera dal 2015 a oggi. Il sito del museo ora offre tutte le informazioni sulle centinaia di puntuali iniziative disponibili. Vale la pena, però, ricordarne alcune, come il riallestimento completo della collezione e degli spazi, legato a un sistema di comunicazione per diversi tipi di pubblico, dove una didascalia scientifica è spesso accostata a una pensata per le famiglie, e in alcuni casi a una cosiddetta “d’autore”, scritta appositamente da un personaggio del mondo della cultura (tra queste, c’è anche quella del premio Nobel della letteratura Orhan Pamuk, autore, tra l’altro, di un romanzo fondamentale per il collezionismo e la museologia come Il Museo dell’Innocenza. Qui il link alla nostra intervista con Pamuk). Alcune didascalie tessili e olfattive, inoltre, hanno inaugurato una fruizione anche multi-sensoriale dell’informazione sulle opere. C’è stata poi l’apertura di nuovi spazi: il Caffè Fernanda e la Bottega Brera, che non vanno intesi come un semplice bar e un bookshop, bensì come “estensioni della pinacoteca di Brera, con funzioni di sale espositive, di laboratori didattici, e di vetrine per tutte le attività del museo e degli altri istituti: la biblioteca, l’osservatorio e l’orto botanico, con un forte accento sul tema dell’aggregazione e della condivisone”. E ancora, le sedie trasportabili e le panche da disegno per i bambini nelle sale sono state introdotte per assecondare un tempo di fruizione più lento e dilatato e per aumentare l’interattività con le opere. Novità educative sono state apportate anche fuori dal museo, con iniziative come la “Coda ludica”, un momento di gioco e di apprendimento pensato per le persone che attendono di entrare nella pinacoteca di Brera nelle domeniche di maggiore afflusso. E la logica dell’inclusione ha interessato anche l’aspetto di comunicazione, con una fervida attività editoriale (33 pubblicazioni dedicate alle opere e alla memoria del museo); con una rinnovata comunicazione on line, con le attività didattiche via Instagram; e con le Brera stoies raccolte sul sito: approfondimenti dedicati alla memoria dei cittadini e dei fatti artistici e che legano il passato e il presente della città attraverso il museo.

Quelli citati sono solo alcuni esempi di un’attenzione rivolta a trasformare la pinacoteca di Brera da “contenitore di capolavori” a “luogo di apprendimento informale”, per citare una formula cara a James Bradburne. Al direttore abbiamo chiesto dunque di ripercorre le tappe del percorso personale, culturale e professionale che lo hanno condotto all’impostazione didattica introdotta a Brera: un approccio che per ampiezza, varietà e sistematicità è difficilmente riscontrabile in altri musei.
Direttore, partiamo dalla sua formazione: diceva che non viene dalla storia dell’arte in senso stretto…
James Bradburne: Ho studiato in Canada e in Inghilterra, mi sono laureato in architettura all’Architectural Association di Londra, poi ho conseguito un dottorato in museologia all’Università di Amsterdam. Al di là dei miei studi regolari, però, la mia formazione è stata profondamente influenzata dall’antropologia. In particolare, devo citare il mio rapporto di collaborazione con la studiosa canadese Drew Ann Wake, che ha avuto un’educazione da antropologa per poi portare l’approccio di quella disciplina nel giornalismo e in seguito – insieme con me – anche alle esposizioni. Il mio incontro Drew Ann risale agli anni 70. In quel periodo, il governo canadese stava avviando uno studio di fattibilità per la realizzazione di un metanodotto nell’estremo Nord-Ovest del Paese. Il giudice Thomas Berger fu incaricato dal governo nel 1974 di indagare sull’impatto sociale, ambientale ed economico dell’opera. La commissione che faceva capo a Berger aveva attraversato tutta l’area interessata dal progetto, e in ogni piccolo villaggio, anche di soli 20 abitanti, apriva un’inchiesta interrogando le persone sull’impatto che l’opera avrebbe avuto sulle loro vite, sui loro costumi, sulla loro sussistenza in termini di attività agricole e di allevamento, e più in generale sulla loro cultura. Tutti venivano interpellati: dagli studenti ai contadini, dai ragazzi agli anziani. La squadra di Berger produsse una immensa documentazione che indusse il governo a sospendere l’idea di costruire l’opera. Drew Ann Wake ha seguito come giornalista, per Radio Canada, questo processo di indagine in tutto l’arco del viaggio, durato due anni. E quell’esperienza è stata fondamentale per dimostrare al pubblico radiofonico l’importanza dell’ascolto, per sottolineare l’opportunità di non imporre decisioni dall’alto quando si tratta di influire sulla vita delle persone. Cito quell’esperienza perché quel metodo ha segnato il mio atteggiamento in ogni museo o centro espositivo in cui abbia lavorato: ho sempre cercato di non calare decisioni dall’alto ma di accompagnarle alle esigenze dei visitatori. Il lavoro di Drew Ann Wake, dunque, anche se non aveva ancora come oggetto i musei, ha per primo influenzato la mia visione di come comunicare, proporre, offrire un’esperienza di fruizione museale.

Che tipo di lavoro avete fatto insieme, lei e Drew Ann Wake?
James Bradburne: Io e Drew Ann Wake ci siamo incontrati nel 1975 quando si è creata la prima radio pubblica cooperativa in Canada, (simile a NPR, la National Public Radio in America), si chiamava Coop Radio; vi abbiamo lavorato insieme come giornalisti nella creazione di diversi programmi. Avevamo trovato un terreno comune nell’importanza che attribuivamo al racconto orale, al processo dell’ascolto, alla centralità delle interviste per raccogliere le memorie e le esperienze di persone che spesso non hanno la possibilità di far sentire la loro voce: tutte componenti – come dicevo – che ho portato in ogni mia esperienza museale, compresa Brera, naturalmente.
Qual è stata la prima significativa esperienza nell’ambito delle mostre?
James Bradburne: Quello per Coop Radio è stato il primo lavoro insieme con Drew Ann, ma la nostra collaborazione è proseguita negli anni successivi in diversi contesti. Per Coop Radio e per Radio Canada lavoravo come producer. Poi passai alla progettazione tridimensionale. Fu in occasione dell’Expo di Vancouver del 1986. Drew Ann Wake lavorava come specialista del contenuto per la realizzazione di alcuni padiglioni. Io lavoravo lì come graphic designer e lei mi domandò se volessi passare dal disegno bidimensionale alla progettazione 3D. Io mi sentivo assolutamente pronto a fare quel salto, dunque accettai. Insieme abbiamo progettato sette padiglioni per l’Expo. Anche in quell’occasione abbiamo messo in atto il nostro approccio antropologico: siamo andati in ognuna delle province, anche nelle zone più profonde del Paese, intervistando gli abitanti per capire realmente l’identità di ogni comunità in funzione degli ambienti che avremmo dovuto progettare per rappresentarle. Gli imperativi per noi erano ascoltare, guardare, registrare, capire e non intervenire, in modo da poter cogliere la vera identità di nuclei sociali e culturali e dunque ideare la soluzione migliore nella realizzazione degli ambienti e delle mostre che li riguardavano.


Qual è stata la prima volta che ha trasferito questo approccio antropologico in un museo?
James Bradburne: Dopo l’esperienza dell’Expo, sono andato a Londra per continuare i miei studi di architettura. Ma siccome non provengo da una famiglia ricchissima e avevo già una certa età, 29 anni, dovevo anche lavorare per vivere. Così, viste le mie precedenti esperienze nell’ambito delle mostre, ho cominciato in Inghilterra a occuparmi di rassegne e allestimenti. In quel periodo lavoravo soprattutto con i musei della scienza. Erano gli anni 80, e in quel momento storico i musei della scienza interattivi si presentavano come la risposta a tutti i problemi museografici: sembrava che l’interattività fosse la sola arma capace di vincere la polverosità di cui erano ammantati i musei. In questo senso credo si sia esagerato, ancora oggi ritengo che per dare freschezza a musei non si debba puntare sulla tecnologia bensì su un nuovo tipo di offerta in relazione ai contenuti. In quel periodo Drew Ann stava lavorando proprio sui contenuti dei musei scientifici. Così, anche se lei viveva a Vancouver e io nel frattempo mi ero spostato a Parigi, abbiamo deciso di mettere a punto soluzioni alternative alla “moda interattiva” allora dominate e di presentarle ai musei della scienza. Abbiamo lavorato insieme per istituzioni europee e canadesi dal 1990 fino al 1994. E il nostro lavoro di quegli anni era molto influenzato dalle ricerche di importanti antropologi e filosofi.
Può fare qualche esempio?
James Bradburne: Posso citare Brian Wynne, che ha studiato l’impatto del disastro di Chernobyl sui contadini; Jean Marc Levy Leblond, filosofo della cultura scientifica e tecnica; il sociologo Jean Davallon e i suoi studi sui musei. Importante è stato anche l’approccio del sociologo della scienza Bruno Latour, che ha fatto notevoli ricerche con il Salk Institute for Biological Studies di San Diego, in California. Interessante è per esempio il suo lavoro di osservazione all’interno dei gruppi di ricerca scientifica: lui operava davvero come un antropologo, non gli interessava capire la scienza, bensì indagare come funzionasse l’”ecosistema” di una squadra di scienziati. Fondamentale per me è stato anche il lavoro di Jorge Wagensberg, grande fisico, che ha collaborato al museo delle scienze di Barcellona. Anche Wagensberg aveva una spiccata sensibilità per questo approccio: osservare e capire come inserirsi in una pratica già avviata.
Che cosa le hanno insegnato questi studiosi?
James Bradburne: La loro lezione si può tradurre nella impostazione fondamentale che ho dato ai musei che ho diretto. In sostanza, invece di arrivare con un’agenda di tipo “top-down”, il mio lavoro può essere definito come un approccio di “bottom-up”, da sotto a sopra. È l’opposto dell’approccio formale, strutturale, scolastico. Ogni mia iniziativa in un museo nasce dall’osservazione e dall’ascolto dei visitatori: delle loro aspettative, delle loro esigenze. Ogni mia proposta tiene conto di quelle indagini. Il mio obiettivo per un museo – dunque oggi per Brera – è quello di creare le condizioni ottimali per un apprendimento informale.
Quali sono le caratteristiche dell’apprendimento informale?
James Bradburne: Normalmente, siamo abituati a un sistema formale di apprendimento, il quale ha come condizione basilare quella di avere delle barriere. Da una parte, infatti, c’è un momento di valutazione, che è all’inizio del percorso: un test dove devo dimostrare di avere le conoscenze preliminari, o meglio, devo dire a che punto della conoscenza sono in quel determinato momento. Dall’altra parte, alla fine del percorso, c’è un’altra barriera: un esame finale, un momento dove devo mostrare dove sono arrivato. Questa è la formalità del sistema scolastico. È “formale” perché ci sono momenti di valutazione esterni. Nel museo, invece, non c’è un test né all’entrata né all’uscita. Un museo non pone condizioni. L’unica condizione per voler andare al museo è di… voler andare al museo. Ebbene, questa è l’essenza dell’informalità: essa non è condizionata da una valutazione. Siamo liberi di godere un museo come vogliamo. È vero che io vedo il museo come un luogo privilegiato nel quale apprendere. Però l’apprendimento non va considerato in un percorso obbligato. In una prospettiva di apprendimento informale, dunque, il nostro incarico (mio e della squadra del museo, intendo) è quello di arricchire il percorso della pinacoteca di Brera con diverse possibilità di apprendere, introducendo in questo processo – possibilmente – anche la gioia dell’apprendere. Ogni visitatore deve poter decidere il proprio itinerario, il proprio bisogno, scoprire il proprio profondo piacere di imparare, senza essere costretto a seguire un itinerario stabilito in partenza. L’informalità deve essere una condizione strutturale del museo.

Dunque, partendo dagli studi di antropologia, anziché intendere il museo come un luogo dove il direttore indica un percorso formativo, lei lo rappresenta invece come un ecosistema?
James Bradburne: Esattamente, il mio approccio è quello di concepire il museo come un ecosistema e di capire le sue diverse condizioni e variabili. Negli anni 90 ho lavorato al museo della scienza di Amsterdam, progettato da Renzo Piano: ero capo del dipartimento del design e della didattica. In uno dei tanti progetti avevamo coinvolto i musicisti Brian Eno e Peter Gabriel. Quest’ultimo mi aveva detto una cosa molto interessante: “Un museo dovrebbe avere le stesse dinamiche di un parco”. Era un’intuizione molto brillante, perché metteva l’attenzione non tanto sul contenuto quanto sul modo di accedere ad esso. Posso andare in un parco per vedere l’oro botanico, per studiare le foglie, oppure per fare una passeggiata o ancora per dare un bacio alla mia ragazza. Nessuno mi dice quale sia il modo giusto di stare in un parco, sono io che trovo il mio modo. Un museo dovrebbe poter offrire la stessa generosità di spirito, accettare la diversità dei suoi visitatori come condizione basilare. Ritengo che questa caratteristica di generosità contenga anche un valore civile molto importante, che corrisponde alla missione sociale di un museo. Queste mie convinzioni hanno profonde radici nel pensiero di figure come il grande psicologo Lev Semënovič Vygotskij, che si è occupato molto di educazione e società, e di George Hein, mi riferisco in particolare ai suoi studi sulla filosofia dell’educazione applicati all’esperienza del museo cosiddetto “costruttivista”.
Il direttore di un museo, secondo lei, non dovrebbe in nessun modo nemmeno abbozzare la direzione di un percorso formativo?
James Bradburne: Certo che deve farlo. Io ho sempre un’idea molto precisa di che cosa il museo possa e debba trasmettere ai suoi visitatori. Solo che non pongo questa mia idea come condizione univoca. L’idea di consentire un apprendimento informale non esclude che io abbia una mia visione sui contenuti di questo apprendimento. La mia posizione però devo considerarla come una ipotesi, e verificarla attraverso l’esperienza reale dei visitatori. La mia ipotesi e le aspettative del pubblico devono andare di pari passo, devono essere abbinate nel terreno comune che è l’ambiente-museo. Riguardo a questo aspetto, per me è stata importantissima anche la scoperta del metodo pedagogico Reggio Emilia, profondamente influenzato da Vygotskij e dal costruttivismo.

In che modo ha applicato il metodo Reggio Emilia all’arte?
James Bradburne: Nel 2003 avevo chiesto al presidente della Lego di fare una piccola fondazione per promuovere la creatività tra i bambini, e nel contesto del suo comitato scientifico ho incontrato Carla Rinaldi, figura chiave di Reggio children, un centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine. Con lei sono nate una grande amicizia e una significativa collaborazione. Reggio children aveva lavorato molto con gli asili e con le scuole, mai però con le mostre. Così io ho portato loro la mia esperienza nell’apprendimento informale nei musei, e da loro ho imparato che oltre all’ascolto è importantissima la documentazione: ascoltare non è sufficiente, dobbiamo rendere questo ascolto visibile, in modo che le persone possano partecipare, aggiungere e condividere le proprie esperienze.
Può fare un esempio di “ascolto visibile” in relazione a un museo o a un’esposizione d’arte?
James Bradburne: Un esempio si può vedere in una delle iniziative che – prima del mio arrivo a Brera – abbiamo realizzato nella mostra Anni 30 a Palazzo Strozzi nel 2012. Alle famiglie in visita fornivamo una valigia che conteneva il gioco del Monopoli (un gioco da tavolo che era stato introdotto in Italia proprio negli anni documentati dalla rassegna). Le famiglie potevano giocare e muoversi sulle caselle del Monopoli da un’opera all’altra tra quelle in mostra. Se però un giocatore capitava in un angolo del Monopoli, dove normalmente è scritto “Vai in prigione”, egli aveva l’obbligo di andare in uno studio radiofonico, allestito nella mostra stessa. In quel luogo i bambini intervistavano gli adulti (i loro genitori e i loro nonni) sulla loro infanzia. E tutti i visitatori della mostra avevano la possibilità di ascoltare. In mostra dunque c’erano gli anni 30 dell’arte, e a questo percorso estetico si aggiungevano gli anni 30 realmente vissuti dai visitatori. Questi elementi si ritrovano anche qui a Brera, non nelle stesse forme, ma nella stessa idea di legare la vita reale delle persone al contenuto del museo.
Quello di Brera è un modello replicabile?
James Bradburne: Fuori dall’Italia ci sono diversi musei che presentano aspetti affini, ma si tratta di esperienze parziali, non conosco un museo che abbia messo a punto un’offerta didattica ampia come quella proposta da Brera negli ultimi quattro anni. Certo, conosco ottimi apparati didattici in diversi musei della scienza, come quello di Boston e quello di San Francisco. Il Getty Museum, inoltre, ha un’interessante offerta educativa. E c’è un museo del libro per bambini a Den Haag che è meraviglioso. Però devo dire che quando sono arrivato a Brera ho iniziato a fare una riflessione (e ho chiesto alla squadra di aiutarmi in questo) sulle mancanze dei musei, e su come sarebbe dovuta diventare Brera per essere un museo ideale. Per “museo ideale” avevamo immaginato un luogo che mettesse al centro della sua missione parole come “inclusione”, “accessibilità”, “accoglienza”, “varietà “, “emozione”. Per arrivare all’obiettivo, abbiamo messo in atto quel processo di ascolto che ho descritto prima. In quattro anni c’è stato il tempo adeguato per filtrare tutta una serie di possibilità che abbiamo sperimentato e di mettere appunto modelli affinati di proposta didattica. Non credo che il nostro modello sia replicabile in altre parti d’Italia o del mondo: il nostro modello per Brera è pensato apposta per Brera, dunque funziona qui perché si basa sulle potenzialità di una precisa collezione, di un preciso spazio, e di un preciso contesto metropolitano. Se dovessi dirlo in una battuta, potrei dire che se il nostro lavoro fino ad ora ha funzionato sulla pinacoteca di Brera è soltanto perché abbiamo ascoltato i bisogni della pinacoteca di Brera, e cioè della sua comunità. Dunque il risultato non è replicabile, e nemmeno è desiderabile che sia replicato poiché ogni museo dovrebbe sviluppare il proprio percorso. Ciò che è applicabile in contesti diversi è però il metodo dell’ascolto visibile, condizione fondamentale per ogni iniziativa didattica.


November 17, 2022