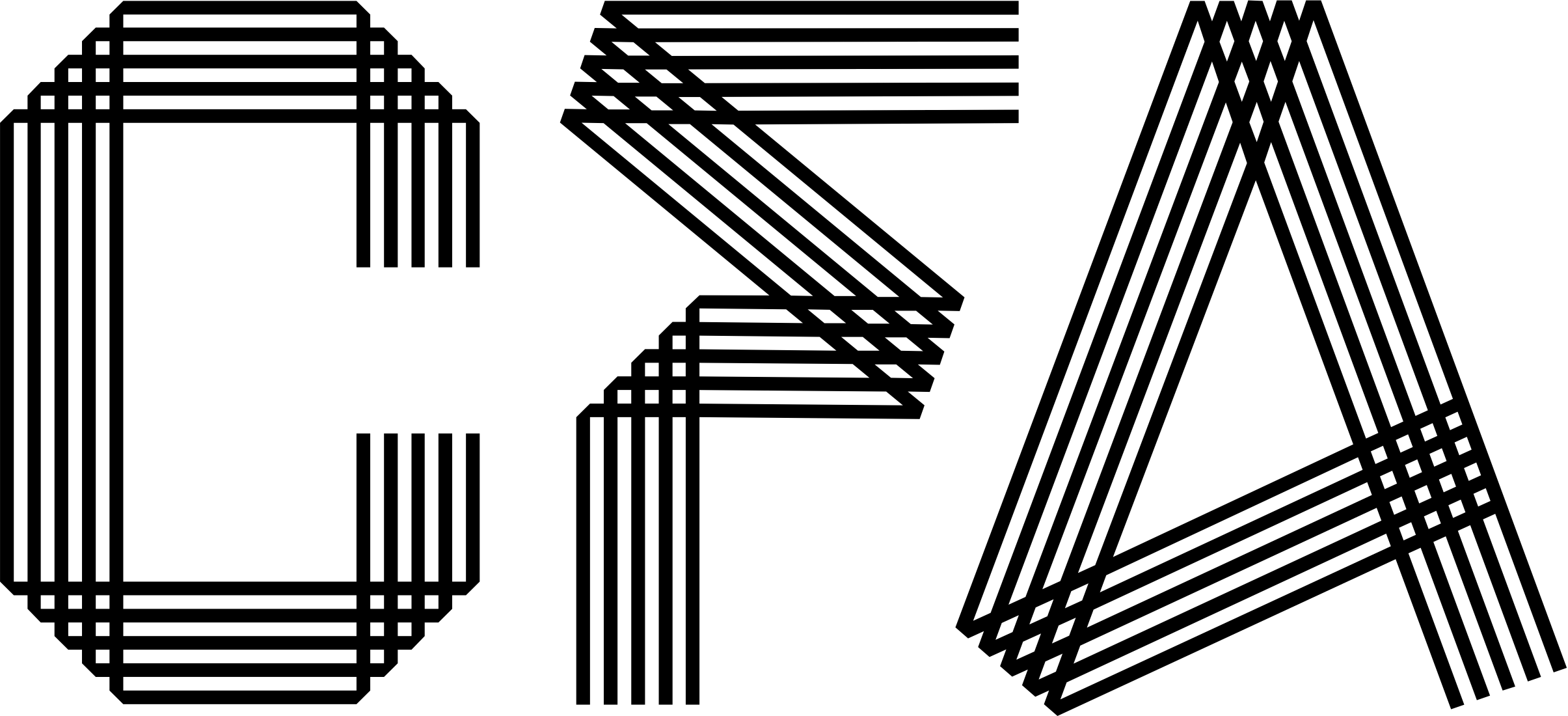Rinascimento privato: l’Apollo di Antonio Minello
Ecco la la tortuosa storia dell’Apollo di Antonio Minello, con le sue molteplici attribuzioni, interpretazioni e illustri proprietari
L’Apollo di Antonio Minello (o Antonio Minelli), un notevole rilievo in marmo bianco, in realtà una figura quasi a tutto tondo alta cm 77, con una montatura in marmo giallo antico non coeva, che si staglia contro una lastra in marmo nero, è un capolavoro della scultura rinascimentale noto da tempo agli studi, ma sostanzialmente trascurato dalla critica moderna. Pubblicato una prima volta all’inizio del secolo scorso, l’Apollo era ricomparso per l’ultima volta sul mercato antiquario nel 1965, cadendo poi nell’oblio, dal quale è riemerso solo adesso. È stato merito di Shelley Zuraw, che lo ha riportato all’attenzione degli studi nel 2016 (quando lo ha riprodotto come un pezzo di ubicazione sconosciuta, in un articolo intitolato, pessimisticamente, “A Lost Apollo”), proporne ipoteticamente il riferimento ad Antonio Minello, un protagonista ancora oggi poco noto della scultura rinascimentale veneta.

L’eccezionalità del pezzo non è dovuta solo alla rarità di opere simili, testimonianze altissime della civiltà umanistica dell’Italia settentrionale e del clima che si respirava nelle maggiori corti quattro-cinquecentesche dell’area padana, da Ferrara a Mantova (quel mondo di lusso e raffinatezza erudita rievocato magistralmente da Maria Bellonci nel suo ultimo, celebre libro, un’autobiografia fittizia di Isabella d’Este uscita nel 1986 con l’evocativo titolo di Rinascimento privato), ma anche alla sua storia collezionistica che, caso davvero fortunato, è possibile ricostruire nelle sue linee essenziali attraverso precisi documenti d’archivio e testimonianze testuali.
L’Apollo riferito a Minello, nato verosimilmente nella Padova umanistica animata dalla cultura che fioriva intorno allo Studio cittadino, e già in possesso magari di un colto collezionista della Serenissima ovvero della corte degli Este o dei Gonzaga, o ancora delle città universitarie quali la stessa Padova o Bologna, è attestato all’inizio del Seicento nella raccolta di uno dei più intelligenti mecenati della Roma di primo Barocco, Costanzo Patrizi. Tra Otto e Novecento l’importante storia collezionistica del pezzo si arricchì di un altro fondamentale capitolo, con il passaggio dell’Apollo nelle mani del conte russo Grigorij Sergheevič Stroganoff, che, sempre a Roma, mise insieme una vastissima, straordinaria raccolta d’arte, poi dispersa poco dopo la sua morte, tra le polemiche di chi, come Roberto Longhi, lamentava quella che era una dolorosa perdita per il patrimonio pubblico italiano.

Mentre, ad esempio, un importante arazzo fiammingo del XV secolo, veniva acquistato dal grande mercante d’arte Joseph Duveen (1869-1939), la scultura allora riferita a Bambaia passava nelle mani di un vorace e ricchissimo collezionista della mitteleuropa, Camillo Castiglioni: il pezzo approdava così a Vienna. Ma Castiglioni, a seguito di un tracollo finanziario, lo rivendeva presto ad una grande asta tenutasi ad Amsterdam nel 1925. Per gli imprevedibili percorsi della storia, quindi, il rilievo veniva infine acquistato da Giuseppe Sangiorgi (1850-1928), titolare di quella che fu probabilmente la più illustre galleria antiquaria romana di primo Novecento, che negli anni precedenti era entrato in possesso di tanti altri ‘highlights’ già nella collezione Stroganoff.
Oggi l’Apollo di Minello è una delle pochissime sculture di destinazione privata e soggetto profano, prodotte dal Rinascimento veneto, a non essere approdata ad una importante collezione pubblica: la maggior parte delle altre è conservata in istituzioni museali straniere di primissimo piano, dal Louvre di Parigi al Victoria and Albert Museum di Londra, e la moderna fortuna internazionale di questi pezzi rispecchia fedelmente l’apprezzamento che gli stessi ebbero fin dall’inizio del Cinquecento, quando furono avidamente ricercati da importanti collezionisti, anche e soprattutto d’Oltralpe. Poiché a quel tempo era difficilissimo, se non impossibile, ottenere pezzi antichi di grandi dimensioni, o anche originali moderni all’antica, quei rilievi marmorei prodotti a Padova (e verosimilmente anche a Venezia) riscossero immediatamente un notevole successo presso la più illustre clientela internazionale, in virtù della loro eccezionale qualità e della facile trasportabilità, viaggiando veloci in qualità quasi di messaggeri della civiltà rinascimentale italiana.

June 11, 2022